Sei in: News » Attualità » Poesia, critica letteraria, illusioni e aspirazioni, di Domenico Pisana
Poesia, critica letteraria, illusioni e aspirazioni, di Domenico Pisana
13/02/2018, 16:39 | AttualitàScrive Berardinelli in un suo articolo (https://www.pressreader.com/): “Sento anche dire, però, che una cosa in Italia splende, fiorisce e trionfa: è la poesia. Pare che ci siano tre milioni di poeti”… Non può che essere così, perché anche se non sono tre milioni ma solo trecentomila o trentamila o mille, è difficile credere che siano tutti poeti e non ci siano tra loro parecchi illusi più o meno candidi, convinti che nessuno si accorgerà che quello che scrivono non è né questo né quello né altro”
Francamente a me non interessa più di tanto quanto siano i poeti! Se la poesia fiorisce a me fa piacere e dico che è un bene che fa sperare. Dico spesso ai giovani: a quelli che vanno incendiando cassonetti o utilizzano spranghe per abbattere vetrate o cedere alla violenza o cadere nella droga o in qualcos’altro, preferisco quelli che si dedicano alla poesia anche per esternare i loro sentimenti di rabbia , di protesta e di denuncia; saranno poesie o pseudo poesie, poco importa. Certo è che la poesia è uno strumento che sicuramente nobilita e innalza l’animo umano.
Mi si potrà dire che questo mio discorso alimenta ancor più confusione, frammentazione e disorientamento, impedendo - come scrive Berardinelli – di poter “scegliere i venti o trenta o quaranta (già troppi!) ‘veri’ poeti”. E, però, mi domando: come si fa a individuare un “vero poeta”. Questo è il problema! Un poeta è vero per il contenuto dei suoi versi? per il suo linguaggio? Per l’uso che fa della parola? Per la forma e lo stile che utilizza? Per la sua originalità? Perché propone una poetica, un progetto, un manifesto? Per la sua appartenenza ad una corrente letteraria? Per il suo radicamento nella tradizione classica? Per tutte queste cose insieme o per cosa altro?
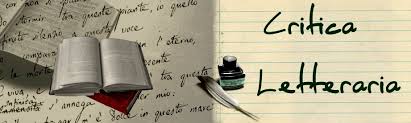 Berardinelli afferma che “C’è chi accusa quei loschi figuri dei critici, i quali si permettono di giudicare con arroganza i manufatti altrui senza essere ( loro) in grado di creare o confezionare niente. Ma i critici, salvo poche eccezioni, non scrivono versi. Il guaio è che non sanno scrivere decentemente molti poeti ben noti”.
Berardinelli afferma che “C’è chi accusa quei loschi figuri dei critici, i quali si permettono di giudicare con arroganza i manufatti altrui senza essere ( loro) in grado di creare o confezionare niente. Ma i critici, salvo poche eccezioni, non scrivono versi. Il guaio è che non sanno scrivere decentemente molti poeti ben noti”.
A mio avviso chI fa critica letteraria non è detto che in automatico possa essere un buon poeta e viceversa, ma che “i critici, salve poche eccezioni, non scrivano versi” ho qualche perplessità.
Ad ogni modo, qui si chiama in causa il compito della critica letteraria e il problema dei “giudizi di valore” . Montalianamente parlando, i “giudizi di valore” sono un azzardo, perché in effetti, come insegnava anche Benedetto Croce, ogni poeta, come anche il musicista, il pittore, nel momento in cui porta una cosa dal non essere all’essere, accade che già l’oggetto del suo parto, cioè l’opera d’arte, è perfetta nel suo cuore e, pertanto, la sua pratica esternalizzazione, sicuramente utile e necessaria, non può aggiungerle nulla.
Un critico letterario non ha, a mio parere, il compito di esprimere “giudizi di valore” affermando qui c’è poesia, qui no, questo è poetico e questo non è poetico ( non vedo cosa possa avere di poetico un uovo, una moneta, un calzolaio, una lettera dell’alfabeto, eppure anche grandi poeti vi hanno dedicato dei versi: Giudici, Raboni, Montale, ad esempio), perché non potrà mai entrare nella dimensione intuitiva e ispirativa di un’opera di poesia, ma può esplicitare la natura del testo sul piano della sua efficacia contenutistica, semantica e formale rispetto al tempo in cui l'opera si situa.
La critica letteraria ha, a mio avviso, un ruolo importante e deve porsi nell’atteggiamento di servizio culturale per il bene della poesia; deve essere trasparente e muoversi nella dimensione veritativa, non lasciandosi fagocitare da amicizie, simpatie, gusti e tendenze, mode e chiacchere, ma dando le ragioni di ciò che afferma con coscienza e competenza.
Purtroppo, bisogna onestamente ammetterlo, esistono oggi critici di estrazione formalista, altri di impronta idealistica, altri ancora dal piglio psicologista, altri di impronta storicistica, ma io credo che nessuno possa affermare di avere la verità in mano. “In disparte metterei – ed è Montale che parla e il suo pensiero è ancora valido – gli ingaggiati, gli intruppati, gli antiautonomisti dell’arte. Per essi l’arte deve servire a qualcosa, e fin qui nulla di male anche se l’asserzione è contestabile; il guaio è che questo servaggio è il prezzo che l’artista deve pagare a determinate ideologie politiche”.
Quale il compito, allora del critico verso la poesia? Chiaramente chi vuole può cimentarsi nello studio della storia della critica per approfondire l’argomento; questo non è il luogo dove è possibile fare ciò. E allora, mi limito solo a qualche osservazione.
Io credo che l’attenzione del critico debba puntare anzitutto lo sguardo sulla parola poetica, poiché un’opera letteraria, poetica o narrativa, è sostanzialmente fatta di parole e con le parole si costruiscono immagini, si attivano metafore, si fanno tropi, si generano simboli, segni e perfino combinazioni fonico- ritmiche, si intrecciano forme, stili, figure retoriche di cui i manuali di grammatica e letteratura sono ricchi. Una poesia, per essere tale, non può fare a meno di queste regole elementari. Un secondo sguardo del critico deve soffermarsi , secondo me, sulle coordinate portanti e complessive dell’opera o delle opere poetiche, cercando di individuare la sua struttura teleologica in ordine ad una dichiarazione di congruenza ad un insieme, ad una prospettiva cognitiva, filosofica, antropologica, etica ed estetica che , legittimamente, il critico può identificare e di cui il poeta può totalmente ignorarne l’esistenza.
E’ con questo atteggiamento che, in genere, mi accosto alla lettura di una silloge poetica; se mi coinvolge e convince, esprimo le mie impressioni critiche, non omettendo anche di rilevare le eventuali ombre. E poi, io credo che in una lettura critica non tutto necessariamente può essere compreso di ciò che scrive un poeta. E la poesia è anche questo: lasciare sospeso il lettore nel mosaico delle allusioni e del mistero.














