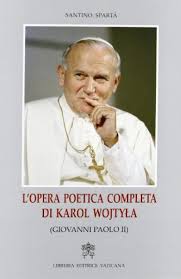Sei in: Rubrica Anniversari » IL POETA IN UNA VEGLIA PASQUALE
IL POETA IN UNA VEGLIA PASQUALE
Giovanni Paolo II a dieci anni dalla morte
02/04/2015, 11:39Dieci anni fa moriva Giovanni Paolo II. Il sacerdote, il vescovo, il papa, il Santo. Il poeta. Era l’aprile del 2005. era nato il 1920. è del poeta che si vuole parlare. Un Canto di Requiem. La poesia di Giovanni Paolo II (autore di opere teatrali oltre che di testi poetici e interventi teorici sul teatro) è mistero e rivelazione. Un dialogare costante con quel linguaggio che non ha mai trascurato il colloquio con l’uomo ma che intrecciava il disegno umano con quello evangelico.
Una poesia nel misterioso del tempo che si allunga tra le ali dello spazio. Pur nella cristianità dell’uomo nella poesia di Giovanni Paolo II si avverte un non voler trascurare l’incontro tra il tempo e lo spazio.
La vocazione alla poesia non sorprende. In questa vocazione, che è sostanzialmente un ricercarsi nella parola e nei linguaggi della letteratura, i riferimenti autobiografici diventano consistenti. La condizione umana, la morte della madre, il senso della solitudine, la guerra, la devastazione del suo paese che si fa sradicamento, la Patria lacerata sono elementi che campeggeranno con insistenza in tutto quel percorso poetico che è l’anima della parola.
In termini sistematici ci sono, comunque, delle tappe fondamentali nella poesia di Karol Wojtyla a cominciare proprio dai versi dedicati alla madre. Il sentimento della perdita si fa subito sentimento di nuova vita. Ed è la consapevolezza del dolore – vita che fortifica quella vocazione poetica che diventa vocazione al sacerdozio, al mistero, al risveglio di un colloquio proprio con quella madre che non c’è più ma che continua ad essere un punto di riferimento.
La poesia si definisce nell’immagine e nelle visioni. Il dolore per la perdita della madre si trasforma in un colloquio e la misura del tempo nella poesia è uno spazio interminabile tra i sentimenti e la parola. La poesia accentua l’altra vocazione che è quella rivolta al sacro. Al di là di ogni elemento puramente religioso il senso del sacro prende il sopravvento sin dalle poesie del 1939.
 Religiosità e letteratura, in Wojtyla, sono un incontro fondante. La parola è teologia di un linguaggio in cui il sacro è una costante rivelazione. In fondo il Wojtyla poeta è padrone, sin dalle prime attestazioni letterarie, del linguaggio e conosce bene i significati dei segni.
Religiosità e letteratura, in Wojtyla, sono un incontro fondante. La parola è teologia di un linguaggio in cui il sacro è una costante rivelazione. In fondo il Wojtyla poeta è padrone, sin dalle prime attestazioni letterarie, del linguaggio e conosce bene i significati dei segni.
Ogni sua poesia è composta come se dovesse essere recitata a voce alta, ovvero è come dovesse porgersi teatralizzata. Ed è un dato importante soprattutto pensando ad un autore che amato il teatro, che è stato autore di opere teatrali e che ha recitato.
Ecco perché quelle sue poesie che occupano proprio la stagione che va dal 1939 al 1944 offrono una chiave di lettura che resta centrale sia in termini di proposta estetica e tematica sia in termini di ricerca linguistica. Si tratta di una prima fase nella quale gli echi e i richiami letterari della sua formazione sono presenti.
Nella poesia successiva, quella degli anni Cinquanta in poi (direi da “Canto dello splendore dell’acqua” a “Pensiero - strano spazio”) si avverte una autonomia sia sul piano stilistico e sia sul piano attraverso una più autorevole impostazione tematica. È naturale che rispetto al periodo precedente si avverte un passaggio da una evocazione-preghiera ad una poesia in cui la preghiera ha una struttura ben consolidata proprio sul piano dello stile poetico.
Nella poesia degli anni Sessanta si sottolinea un modello prosastico che si mostra con una profonda interiorizzazione di alcuni temi che sono stati sottolineati fin dall’inizio. Ed è una stagione questa che va fini agli anni Settanta anche se la ricerca di questa fase subisce dei momenti di sperimentalismo anche sul versante della proposta contenutistica.
Mi riferisco ai versi di “Nascita dei confessori” del 1961 o a “Chiesa i pastori e le fonti” in cui il tema liturgico ha una sua prevalenza mentre in “Pellegrinaggio ai luoghi santi” si vive una poesia fatta di grandi immagini e di grande complicanze sacro-esistenziali. Questi versi appartengono al 1965. ed è qui che quella forma prosastica ha una forza ben marcata.
C’è un’altra componente in questi versi che è la metafora la quale domina gran parte del poetare. La metafora del luogo che è una metafisica del sacro si recupera nel disegno letterario mentre la centralità dell’uomo diventa essenza e tempo. Proprio qui l’uomo è considerato “il continente”.
Comunque c’è una eterogeneità di modelli. Infatti in alcuni versi dell’anno successivo si ritorna a un modello confessionale, nonostante l’insistere sul concetto di tempo: mi riferisco ai versi di “Veglia pasquale”.
La parola, il mistico sentiero di questo viaggio, regala visioni e immagini ma soprattutto ci penetra con quello arcano sentire in cui il senso del sacro è un viatico che segna i passi del quotidiano.
Una poesia dai toni forti ma non urlata. Sottesa ma molto lancinante che scava nella coscienza degli uomini e ci fa superare il deserto perché ci fa andare oltre le ombre o ci fa restare nel deserto perché ci vuole offrire il colore di un crepuscolo che proietta sulla sabbia la nostalgia della fede, ovvero la nostalgia di Cristo.
È proprio in questi versi che la nostalgia del sacro e la nostalgia dell’immagine di Gesù rappresentano il principio e la rivoluzione della parola in una atmosfera di nenie antiche che non hanno lamenti ma solo segni e riti che ci suggeriscono non pensieri ma contemplazione.
È qui ancora una volta che la nostalgia ci riporta al Risorto in un viaggio che è appunto di Redenzione.
Il tema del viaggio resta dunque fondamentale. E questo viaggio indefinibile e indimenticabile non fa altro che metaforizzare un tempo che non conosce l’orologio attraverso una melodia che la poesia ci rende corale.
In fondo la poesia di Wojtyla o di Giovanni Paolo II ci mette sempre in ascolto o ci pone sempre in ascolto di un’arpa. Proprio di quella arpa e di quelle sue poesie giovanili che ritornano come un canto o come un volo di ali, infatti “L’arpista” è un suo cantico pubblicato per la prima volta nel 1999 nel quale la melodia del tempo è un trascorrere di sensazioni nelle immagini che ci riconducono al sempre.
Il cantico dell’uomo e della fede che disegna la speranza e l’attesa in quella luce che va oltre il deserto. O in quella luce che vive dentro il deserto.
È questa la poesia di un uomo che ha attraversato da viandante i viaggi della nostra epoca portandovi dentro l’immenso e l’universo, il sacro in una parola infinita che è quella della Passione e della Redenzione.